Introduzione
L’inverno 2012-2013 è stato dominato da una lunga fase caratterizzata da una notevole dinamicità che ha portato a più riprese ad abbondanti nevicate sulle Alpi Orientali, con massimi accumuli localizzati spesso sulle Prealpi vicentine. L’aspetto più rilevante rispetto alla maggioranza degli inverni degli ultimi 25 anni risulta il fatto che già a quote intorno ai 500 m s.l.m. si è avuta una copertura nevosa continuativa di quasi 80 giorni. A quote superiori ai 1300 m s.l.m. gli spessori di neve, tra fine marzo ed inizio aprile, hanno raggiunto valori prossimi a quelli registrati nell’inverno eccezionalmente nevoso del 2008/09.
La stagione invernale è iniziata il 3 dicembre con l’ingresso di correnti settentrionali di aria fredda e secca che hanno determinato la fine dell’ultima fase perturbata del mese di novembre, quando una depressione sul Golfo di Genova aveva portato, dal 26 novembre al 2 dicembre, abbondanti precipitazioni. In modo altrettanto netto, come traspare dall’andamento delle temperature e delle precipitazioni in Fig. 1, la stagione invernale può essere suddivisa in tre diverse fasi:
- fase fredda dal 3 al 15 dicembre, con due nevicate in pianura, nei giorni 7 e 14;
- fase mite ed asciutta dal 16 dicembre al 12 gennaio, con temperature a più riprese molto elevate per il periodo;
- fase dinamica e nevosa dal 13 gennaio al 9 aprile, con massimi spessori di neve al suolo raggiunti a fine febbraio a quote collinari e a fine marzo sulle zone montane.
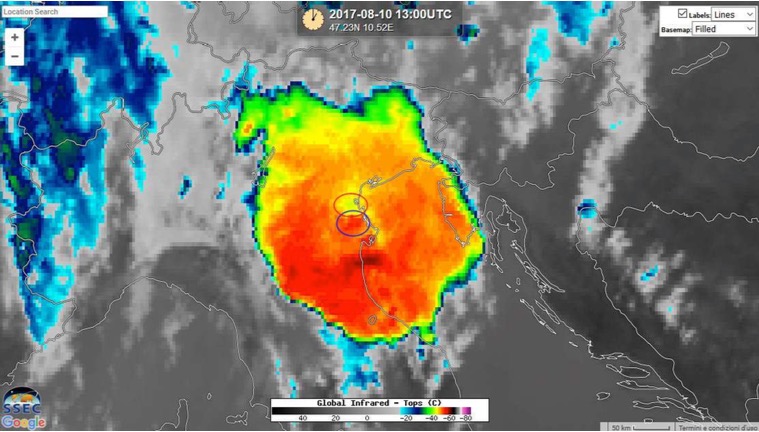
Fig. 1 Andamento delle temperature minime, massime e delle precipitazioni registate a Malo (Vi), 120 m s.l.m., dal 3 dicembre 2012 al 9 aprile 2013.
Prima fase dell’inverno
Dopo una lunga fase piovosa tipicamente autunnale, il 3 dicembre il Nord Italia, tra l’alta pressione atlantica e una bassa pressione sul Mar Nero, è interessato da correnti settentrionali che determinano un miglioramento del tempo e una diminuzione delle temperature. La prima nevicata in pianura si verifica tra il 7 e l’8 dicembre, quando nella pianura lombardo-veneta cadono fino a 10 cm di neve. Il radiosondaggio riportato in Fig. 2 e l’immagine in Fig. 3 riportano la situazione termica e barica nelle ore precedenti la nevicata.

Fig. 2 Radiosondaggio delle ore 12 del 7 dicembre, che riporta il profilo termico precedente la nevicata: la temperatura è al di sopra dello zero ma, essendo la temperatura di rugiada di circa -8°C, la situazione è favorevole alla caduta di neve in pianura.
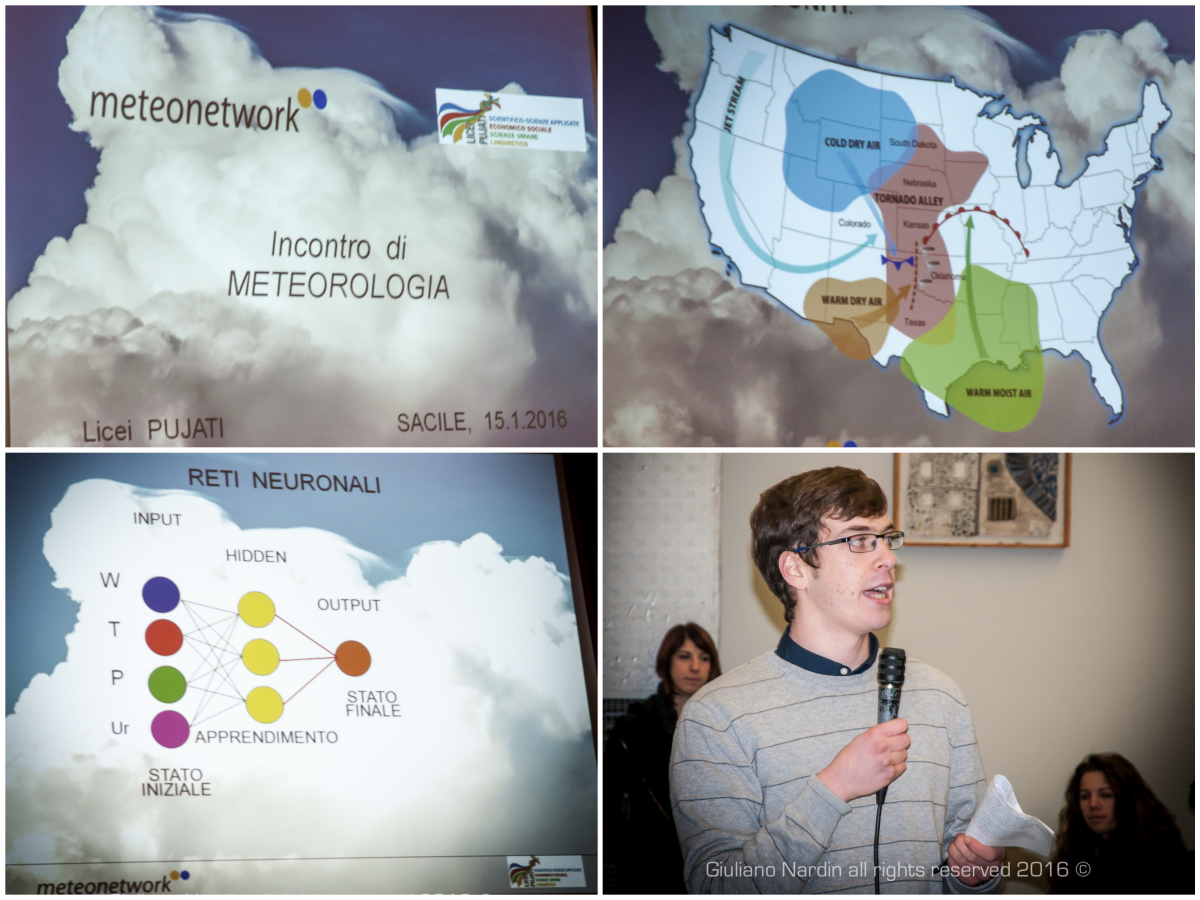
Fig. 3 La differenza di geopotenziale tra 500 e 1000 hPa evidenzia la presenza di aria fredda sul centro-est Europa.
Tra il 13 e il 14 dicembre si verifica la seconda nevicata in pianura. Il contesto è dominato da una vasta depressione sull’Atlantico (Fig. 4) che determina l’afflusso di correnti occidentali sul nord Italia. L’aria fredda preesistente (Fig. 5) favorisce precipitazioni nevose anche in pianura, con successivo innalzamento della quota neve dal 14 dicembre. Le precipitazioni sono di debole intensità, a Milano cadono 8 cm di neve, 5 cm in pianura nel vicentino.
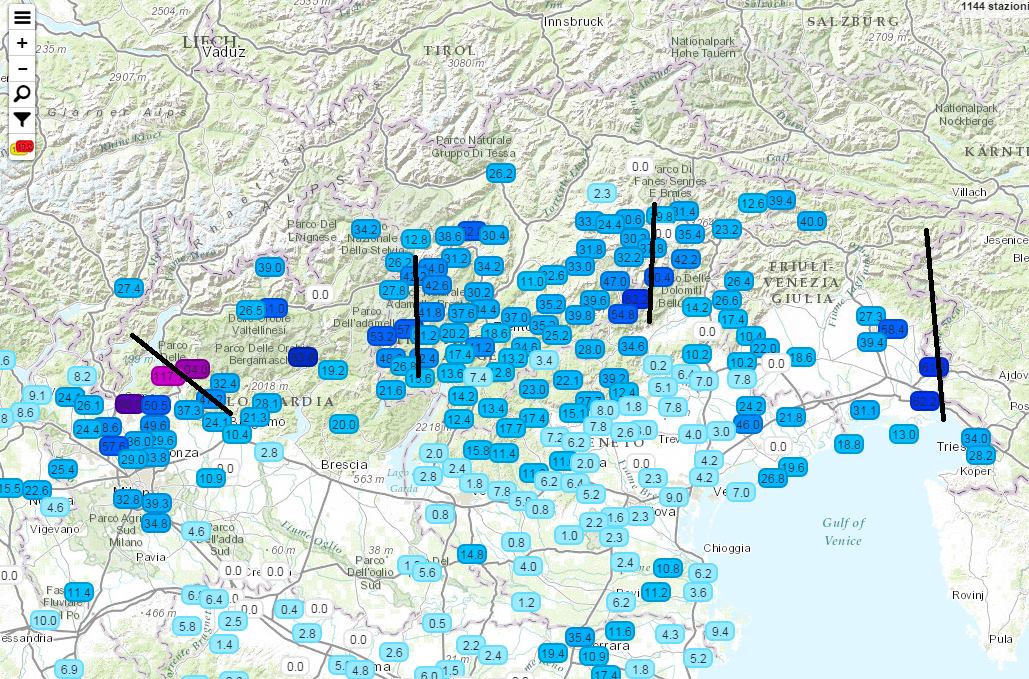
Fig. 4 La vasta depressione sul nord Atlantico determina correnti sud occidentali sul nord-Italia, mentre l’alta pressione sui balcani è associata ad aria molto più fredda.

Fig. 5 Dal riadiosondaggio precedente la nevicata si nota come la temperatura di rugiada sia ampiamente negativa, situazione favorevole all’accumulo di neve in pianura: nel corso dell’evento la temperatura si manterrà di poco inferiore allo zero, prossima alla temperatura di bulbo umido ricavabile dal radiosondaggio.
Seconda fase dell’inverno
La seconda fase dell’inverno, caratterizzata da temperature a più riprese elevate per il periodo, inizia il 16 dicembre quando si verifica un marcato rialzo della temperatura in quota: le correnti si dispondono infatti lungo i paralleli con conseguente afflusso di aria umida e mite.
Il 22 dicembre un fronte caldo raggiunge l’Europa centrale, creando i presupposti per un significativo rialzo termico. Le precipitazioni sul versante nord alpino sono abbondanti, fino a 50 mm in 24 ore, e questo è legato alla differenza di temperatura tra l’aria prefrontale e postfrontale, e quindi alla presenza di aria molto mite dietro il fronte caldo. Per di più il fronte freddo, che normalmente segue nel giro di poche ore attenuando l’effetto di riscaldamento, in questo caso è giunto dopo più di due giorni.
Il 23 e soprattutto il 24 dicembre lo zero termico si porta infatti oltre i 3000 m, con temperature eccezionalmente elevate in tutta regione alpina (ad esempio 18,9 °C a Friburgo, dato DWD). Dalla Fig. 6 si nota l’ampio settore caldo compreso tra il fronte caldo sull’Europa orientale e il fronte freddo sul Mare del Nord (che ha raggiunto il nord Italia nel giorno di Natale). Il 2012 si conclude con tempo sereno e, come si nota dalla Fig. 7, scarsa copertura nevosa sulle Prealpi.
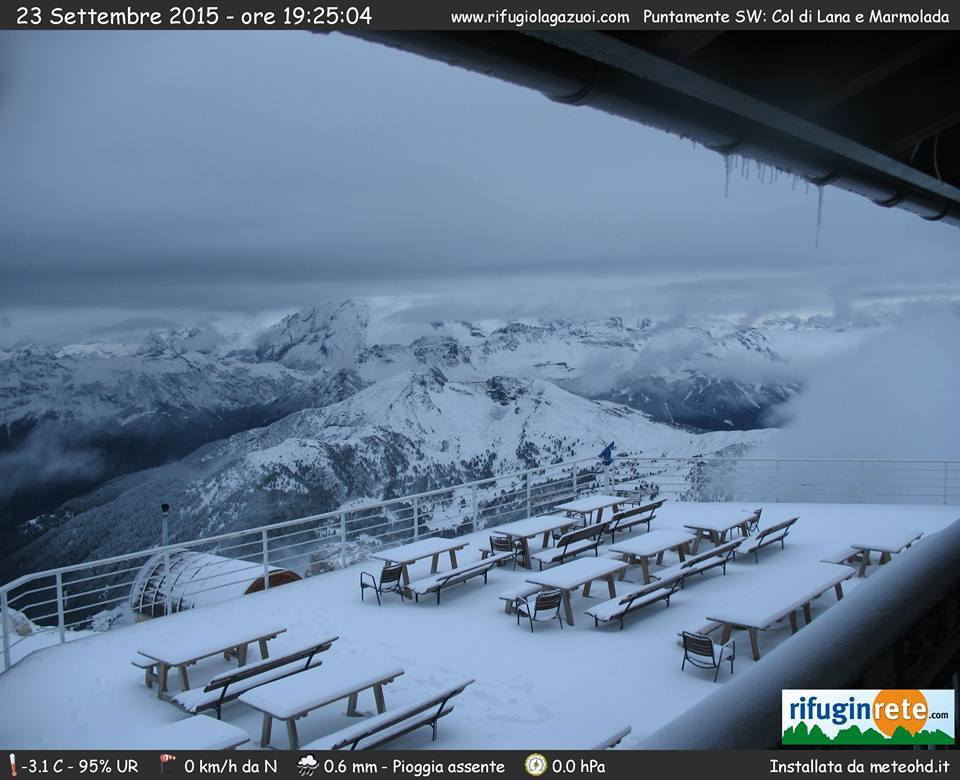
Fig. 6 Campo barico al suolo il 23 dicembre, da cui si nota l’ampio settore caldo che coinvolge la regione alpina.

Fig. 7 Immagine satellitare del 31/12/2012.
Il 5-6 gennaio lo zero termico sale nuovamente oltre i 3000 m. Anche in questo caso nei giorni precedenti (4 gennaio) si erano verificate piogge sul versante nord alpino e in seguito un ampio settore caldo ha coinvolto la regione alpina.
Nella seconda settimana di gennaio il nord Italia rimane interessato dall’alta pressione atlantica: come evidenzia la Fig. 8, il clima risulta mite in quota, mentre in pianura domina la nebbia (Fig. 9).
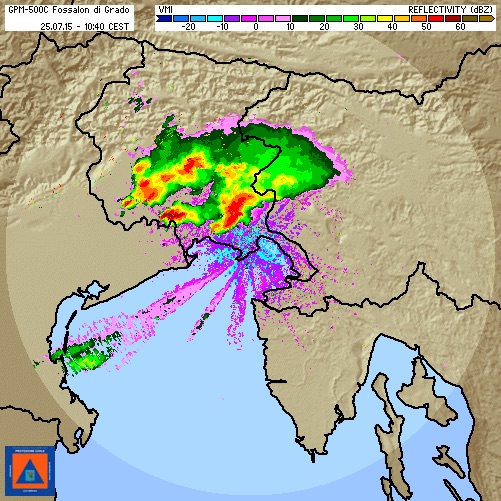
Fig. 8 Radiosondaggio dell’8 gennaio: in corrispondenza del limite dell’inversione termica si ha un netto rialzo della temperature e una diminuzione dell’umidità.
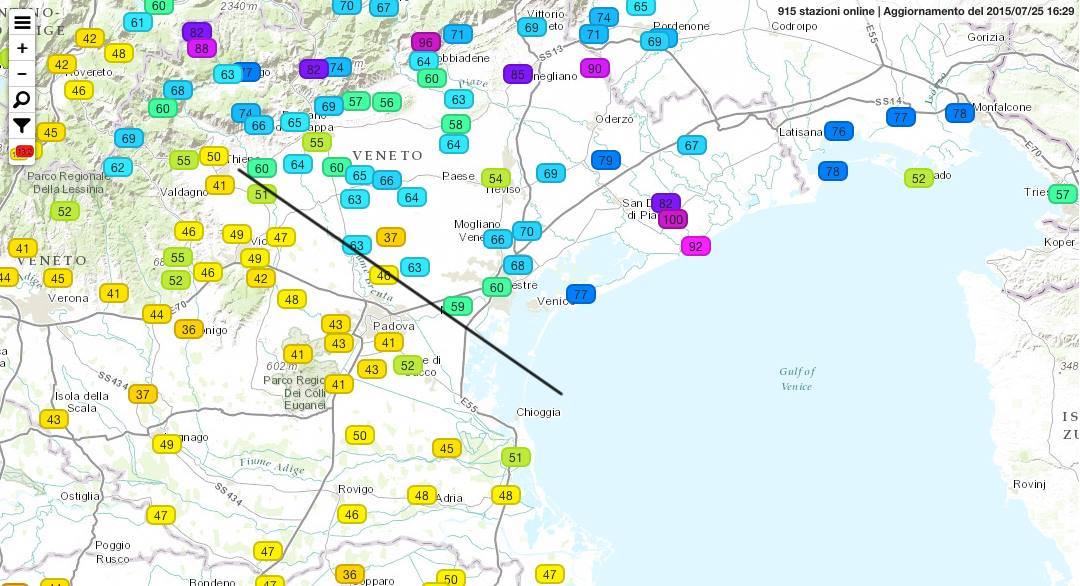
Fig. 9 Immagine satellitare dell’8 gennaio: la pianura padana è interamente coperta dalla nebbia.
Terza fase dell’inverno
Il 13 gennaio si ha una netta svolta della stagione invernale, con l’inizio di una lunga fase che è stata caratterizzata, dal punto di vista meteorologico, dai seguenti aspetti:
- forte dinamicità: afflussi di aria fredda sono stati rapidamente seguiti da perturbazioni che hanno portato anche a più di 50 cm di neve in 24 ore fino a quote collinari;
- in particolare tre giorni (16 gennaio, 11 febbraio, 18 marzo) hanno caratterizzato la stagione invernale, con forti nevicate che da sole hanno contribuito a circa il 35 % della neve caduta nell’intera stagione invernale;
- la traettoria delle perturbazioni e la localizzazione dei minimi depressionari ha spesso portato alle nevicate più abbondanti sul Veneto. Per esempio, dal 13 gennaio al 9 aprile, sulle Prealpi lombarde si sono registrati quantitativi di precipitazione dell’ordine di 250 – 300 mm (ad es. 265 mm a Lecco, dato ARPA Lombardia), mentre sulle Prealpi vicentine i quantitativi nello stesso periodo sono più che doppi (735 mm al Rifugio La Guardia, dato ARPAV).
Il 13 gennaio grazie all’afflusso di aria fredda da nord-est e all’aria calda preesistente, si forma una bassa pressione al largo della Costa Azzurra. Dalla Fig. 10 si nota la bassa pressione che inizia a coinvolgere il nord Italia, la saccatura a 500 hPa (leggermente più a ovest della depressione al livello del mare, condizione favorevole per lo sviluppo della bassa pressione), il contrasto termico che determina il fronte freddo a ovest della bassa pressione e il fronte caldo a est.
Il 14 e il 15 gennaio le neve continua ad interessare il nord Italia, a tratti anche in pianura. Il 16 gennaio la bassa pressione, alimentata da un afflusso di aria fredda diretto proprio verso le Alpi, raggiunge la massima intensità e si sposta verso est. Il nord Italia risulta diviso in due: tratti soleggiati in Piemonte, deboli precipitazioni intermittenti in Lombardia e forti nevicate in Veneto. L’intensità delle precipitazioni è tale che sulla pianura vicentina la neve si accumula sul suolo e sulle strade bagnate da giorni di pioggia raggiungendo spessori di 15 cm.
Il 17 gennaio (Fig. 11) la bassa pressione si colma di aria fredda, le temperature raggiungono i valori minimi e le precipitazioni tendono progressivamente ad esaurirsi nel corso della giornata, rimanendo nevose anche in pianura. I maggiori spessori di neve si osservano sulle zone collinari dell’alto vicentino più esposte alla pianura, dove la coltre nevosa raggiunge localmente il metro di spessore già a 500 m di quota (Fig. 12a,b).
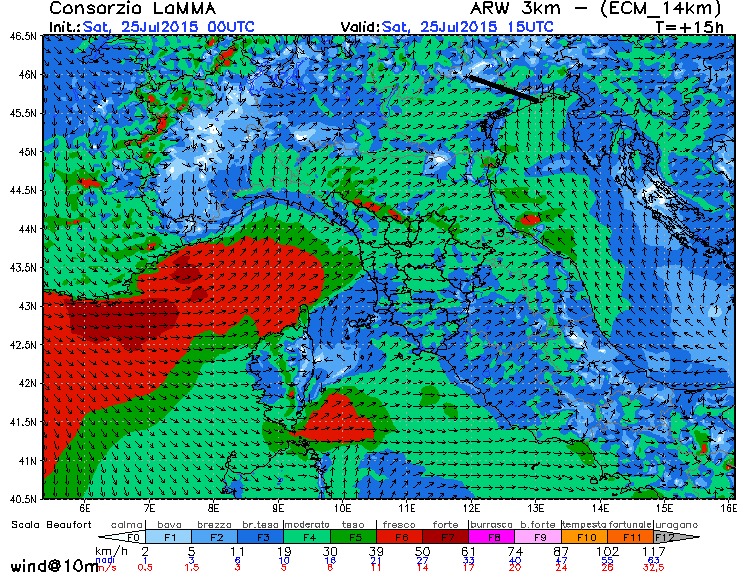
Fig. 10 Il 13 gennaio la bassa pressione tra Corsica e Costa Azzurra inizia ad apportare precipitazioni sul Nord Italia.
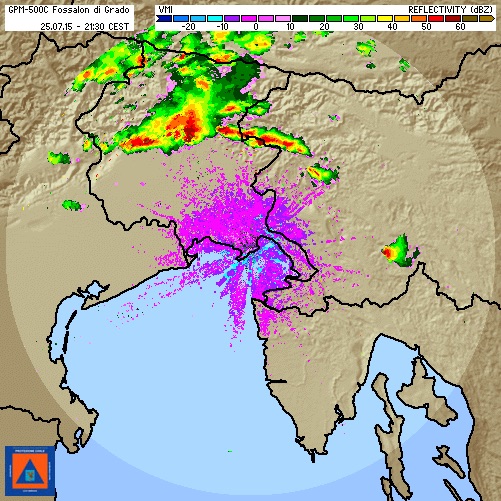
Fig. 11 Posizione della stessa depressione il 17 gennaio: in 4 giorni lo spostamento verso est è stato modesto e le precipitazioni sono quindi rsultate persistenti.


Fig. 12 a,b Le foto sono state scattate il 19 gennaio a Faedo (comune di Monte di Malo, provincia di Vicenza) a quota 600 m s.l.m.
Tra il 19 e il 24 gennaio si susseguono altre perturbazioni con precipitazioni perlopiù deboli e limite della neve generalmente superiore ai 1000 m s.l.m.. Il 28 gennaio torna la neve a bassa quota, con accumuli minimi in pianura e 10 cm sulle zone collinari. Nei giorni successivi l’alta pressione atlantica si espande sul nord Italia, caratterizzando il clima con inversioni termiche e quindi diffuse nebbie in pianura.
Dopo il passaggio di una perturbazione il 2 febbraio (10 cm di neve sopra i 1000 m), fino 6 febbraio il tempo rimane soleggiato. Nel pomeriggio del 7 febbraio inizia ad affluire aria fredda (Fig. 13): dai radiosondaggi dei giorni successivi (in Fig. 14 si riporta per esempio quello dell’8 febbraio) si nota un forte gradiente termico verticale, tipico più dell’estate che dell’inverno. Il veloce afflusso di aria molto più fredda rispetto a quella presente porta allo sviluppo di imponenti nubi cumuliformi, con instabilità pomeridiana sulla fascia prealpina e pedemontana associata a rovesci di neve che portano ad accumuli di 2-5 cm anche in pianura.
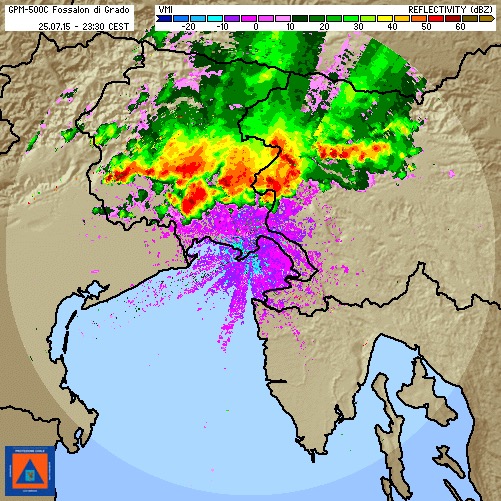
Fig. 13 Fase iniziale dell’afflusso di aria fredda sul nord Italia.
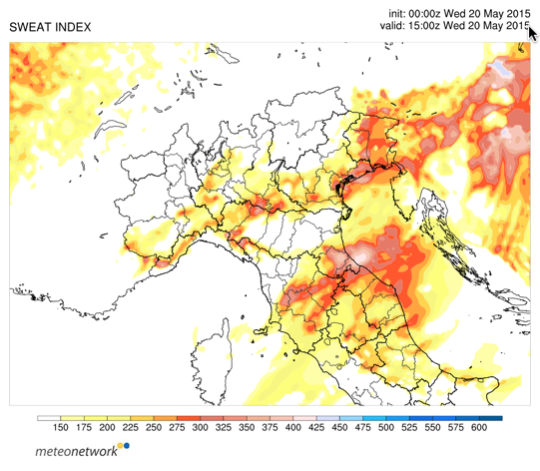
Fig. 14 Il profilo termico evidenzia un forte gradiente termico verticale.
Con tempismo perfetto, dopo un afflusso di aria fredda così rapido da provocare fenomeni di instabilità atmosferica, lunedì 11 febbraio giunge da sud-ovest un’intensa perturbazione. A Milano inizia a nevicare alle 7 e la fase più intensa dura dalle 12 alle 19, nelle zone più aperte si accumulano fino a 15 cm di neve. In Veneto la nevicata inizia nel primo pomeriggio, diviene subito intensa ed entro sera sulla pianura vicentina si accumulano 18 cm di neve.
Dalla Fig. 15 si nota la bassa pressione tra Inghilterra e Francia, che nel suo moto antiorario sospinge correnti sud-occidentali sul nord Italia, e l’alta pressione colma di aria fredda appena a est dell’Italia che, con la sua posizione, contribuisce a indirizzare la perturbazione esattamente sul nord Italia. A Milano, dopo una nottata ventosa con deboli nevicate intermittenti, dalla tarda mattina del 12 febbraio compiano i primi tratti soleggiati. In Veneto continua a nevicare intensamente per tutta la notte, nella mattinata del 12 febbraio il limite della neve si innalza fin sui 300 m s.l.m. e nel corso del pomeriggio le precipitazioni si esauriscono. In pianura il manto nevoso raggiunge i 20 cm, mentre al di sopra dei 300 m s.l.m. lo spessore di neve fresca supera diffusamente i 50 cm. L’immagine satellitare riportata in Fig. 16 si riferisce al 14 febbraio: la pianura padana, ad eccezione dell’alto Piemonte, alta Lombardia e basso Veneto, è ancora ricoperta di neve.

Fig. 15 L’11 febbraio il nucleo di aria fredda si sposta a est e il nord Italia è interessato da correnti da sud-ovest.

Fig. 16 Immagine satellitare del 14 febbraio.
Il 21 febbraio torna nuovamente a nevicare in pianura: a Milano la nevicata inizia già in mattinata, ma senza accumuli al suolo. Nell’alto vicentino, interessato da aria più fredda (Fig. 17), la nevicata inizia nel tardo pomeriggio, prosegue per tutta la notte, e porta all’accumulo di 10 cm in pianura e 20 cm sui rilievi.
Dal pomeriggio del 23 febbraio inizia nuovamente a nevicare in pianura, nel corso della notte il limite della neve risale fino a 400 m s.l.m., a quote superiori cadono 15 cm di neve. Tra il 24 e il 25 febbraio altre nevicate interessano le Prealpi vicentine, con apporti di neve molto variabili da zona a zona. La vasta circolazione depressionaria (Fig. 18), nel suo moto antiorario, fa sì che le precipitazioni sul Veneto provengano dai quadranti orientali.

Fig. 17 Il contrasto termico sul nord Italia determina nuove nevicate anche in pianura localizzate prevalmentemente sul nord-est, interessato da aria più fredda.

Fig. 18 Vasta bassa pressione responsabile delle nevicate del 24 e 25 febbraio.
Sono questi i giorni in cui, a quote comprese tra i 400 m e i 1300 m s.l.m., si raggiungono i massimi spessori di neve al suolo, diffusamente superiori al metro (Figg. 19-20).
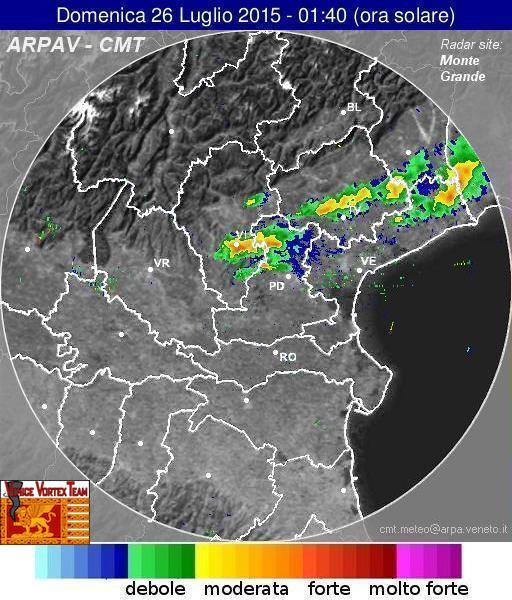
Fig. 19 Altopiano dei Sette Comuni: area pic nic presso Malga Granezzetta (1260 m s.l.m.), 23 febbraio.
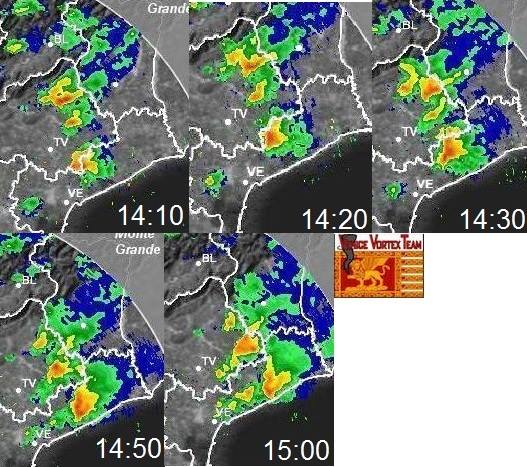
Fig. 20 Loc. Faedo (600 m s.l.m.), comune di Monte di Malo, 24 febbraio.
Nei giorni successivi l’inverno sembra volgere al termine, tuttavia dal 12 marzo un’estesa massa di aria molto fredda in discesa dal nord Europa determina diffuse precipitazioni lungo il fronte di separazione tra l’aria fredda in arrivo e quella più calda preesistente (a Parigi cadono 18 cm di neve, ad Amburgo 27 cm). Il 14 marzo la massa d’aria di origine artica raggiunge le Alpi (Fig. 21) portando un abbassamento dello zero termico fin sotto i 1000 m s.l.m. (Fig. 22).

Figg. 21 Tra il 14 e il 15 marzo l’aria fredda raggiunge il nord Italia.

Fig. 22 Radiosondaggio del 16 marzo: lo zero termico è a meno di 1000 m s.l.m. e la temperatura di rugiada inferiore a -10 °C anche nei bassi strati.
Tra il 15 e il 18 marzo si verifica una replica dell’evento dell’8-11 febbraio in quanto, al rapido afflusso di aria molto più fredda di quella preesistente, il 18 marzo segue da sud ovest una perturbazione che porta forti nevicate inizialmente anche in alcune zone di pianura. La Fig. 23 illustra una configurazione molto simile a quella dell’11 febbraio: la bassa pressione è sempre centrata tra Francia e Inghilterra e determina, nel suo moto antiorario, una circolazione da sud-ovest sul nord Italia. Sui Balcani è presente un’alta pressione e la perturbazione è diretta esattamente sul nord Italia.
Dopo giornate perlopiù soleggiate, nella sera del 23 marzo inizia una nuova fase perturbata che durerà per più di una settimana, con limite delle nevicate sempre inferiore ai 1400 m, a tratti anche in pianura.
Dopo abbondanti precipitazioni il 24 marzo (Fig. 24), nel pomeriggio del 25 marzo le temperature subiscono un notevole abbassamento: il moto antiorario attorno alla depressione sul centro Italia favorisce infatti l’ingresso di aria fredda da est che il 26 marzo porta a diffuse nevicate sul Veneto, anche lungo la costa, ma con accumuli solo sui rilievi.

Fig. 23 Il 18 marzo correnti sud occidentali affluiscono sul nord-Italia precedentemente interessato da aria fredda.

Fig. 24 Bassa pressione sul medio Tirreno responsabile delle precipitazioni del 24 e 25 marzo.
Giovedì 28 marzo il nord Italia è interessato da un fronte caldo che, grazie all’aria fredda preesitente, porta 30 cm di neve fresca al di sopra dei 1000 m di quota (Fig. 25 a,b ). Il 30 marzo nuove precipitazioni, a tratti anche forti, interessano il nord Italia con limite della neve in abbassamento da 1400 a 1000 m s.l.m. sulle Prealpi vicentine grazie anche alla crescente intensità delle precipitazioni.


Figg. 25 a,b Insegna turistica presso il passo di Campogrosso (1464 m s.l.m.) fotografata il 29 marzo e il 26 aprile.
Dalle ore centrali del 31 marzo, giorno di Pasqua, si ha lo sviluppo di nubi cumuliformi favorite dal riscaldamento diurno e dall’aria fredda in quota (Fig. 26). Nel pomeriggio, in montagna, si verificano inizialmente scrosci di neve pallottolare seguiti da un’intensa nevicata al di sopra degli 800 m s.l.m.; la pianura viene invece imbiancata dalla grandine. Il notevole gradiente termico verticale che traspare dal radiosondaggio riportato in Fig. 27 spiega la forte instabilità pomeridiana.

Fig. 26 Afflusso di aria fredda che ha determinato i fenomeni di instabilidà pomeridiana il 31 marzo..

Fig. 27 Il profilo termico evidenzia un accentuato gradiente termico verticale.
L’1 e il 2 aprile il tempo risulta variabile, con tratti soleggiati e brevi nevicate pomeridiane al di sopra dei 1300 m s.l.m.


Figg. 28-29 Altopiano dei Sette Comuni, malga Fiaretta (1600 m s.l.m.), 2 aprile.
Seguono giornate prevalentemente soleggiate fino al 5 aprile, giorno in cui una perturbazione interessa nuovamente il nord Italia, con neve sopra i 1200 m (20 cm di neve fresca a 1500 m s.l.m.).
Il 6 e il 7 aprile il tempo rimane variabile, con tratti soleggiati alternati a deboli nevicate al di sopra dei 1500 m s.l.m., dove lo spessore del manto nevoso non subisce sostanziali modifiche (Figg. 30-31).


Figg. 30-31 Altopiano dei Sette Comuni, rifugio Moline (1740 m s.l.m.), 6 aprile.
L’8 aprile deboli precipitazioni, accompagnate da un abbassamento delle temperature, interessano il nord Italia, con neve sopra i 1200 m. Il tempo si mantiene piovoso anche il 9 aprile, con il limite della neve in innalzamento a 1500 m s.l.m.. Sono queste le ultime nevicate sulle Prealpi, a cui segue un graduale miglioramento. Dal 9 al 14 aprile si verifica un significativo rialzo delle temperature, con valori che tuttavia rimangono nella norma del periodo. Il manto nevoso rimane su valori prossimi a quelli dell’eccezionale inverno 2008-09 (Figg. 32-33).

Fig. 32 Cima Dodici il 14 aprile.

Fig. 33 plateau sommitale del Monte Ortigara (2105 m s.l.m.) il 14 aprile.
Dal 15 aprile le temperature aumentano ben oltre la norma del periodo, ponendo definitivamente fine alla stagione di accumulo su tutte le Prealpi. Al di sopra dei 1500 m s.l.m. l’innevamento si mantiene abbondante fino al 26 aprile, solo a seguito delle piogge del 27-30 aprile, il manto nevoso diviene discontinuo anche al di sopra dei 1500 m di quota.
Bibliografia
- http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html: da questo sito sono stati scaricati i radiosondanggi (nomogrammi aerologici di Herlofson);
- http://www.knmi.nl/waarschuwingen_en_verwachtingen/weerkaarten.php?lang=en: da questo sito sono state scaricate le immagini raffiguranti le isobare al livello del mare;
- http://www.wetter3.de/animation.html: da questo sito sono state scaricate le immagini raffiguranti l’andamento delle isobare al suolo, del geopotenziale a 500 hPa e la rappresentazione tramite scala di colori della differenza di geopotenziale tra le superfici isobariche 1000 hPa e 500 hPa;
- http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?subset=AERONET_Ispra: da questo sito sono state scaricate le immagini satellitari;
- http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/richiesta-dati-misurati/Pagine/RichiestaDatiMisurati.aspx: da questo sito possono essere richiesti i dati registrati dalle stazioni della rete di misura meteo dell’ARPA Lombardia;
- http://www.arpa.veneto.it/upload_arabba/bollettino_neve/DolomitiNeveAlSuolo.pdf: in questa pagina web sono disponibili gli spessori di neve fresca e di neve al suolo in varie località del Veneto;
- http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/dati_rete/vicenza.html: in questa pagina web sono disponibili i dati registrati negli ultimi 60 giorni dalle stazioni della rete di misura meteorologico dell’ARPAV;
- http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/idrologia/file-e-allegati/rapporti-e-documenti/idrologia-regionale/idrologia-regionale-rapporti-sulla-risorsa-idrica: a questo link si trovano i “Rapporti sulla risorsa idrica in Veneto”.