Introduzione
Con questo studio si vogliono andare a ricercare i rapporti di causa-effetto associati ad un determinato evento, individuato da numerosi altri lavori elaborati da studiosi di calibro internazionale, cioè l’ipotetico condizionamento della troposfera da parte della stratosfera a seguito del superamento della soglia NAM di 1,5 a 10 hPa. Lo scopo finale è la differenziazione di questi eventi e la possibilità di prevederne i modi di realizzazione e le successive conseguenze troposferiche e stratosferiche. Nella ricerca dei dati è presa in considerazione la fase di attività del Vortice Polare Stratosferico (ottobre-aprile) con range temporale che va dal 1978 al 2012 e in caso di più superamenti nella stessa stagione si conterà solamente il primo evento.
Fase 1: individuare eventi di superamento soglia e relativo ipotetico condizionamento troposferico
Dei 34 anni analizzati sono ben 26 quelli in cui la soglia è stata superata almeno una volta
Anno Data superamento
78/79 08/01/1979
79/80 14/01/1980
80/81 13/12/1980
81/82 16/03/1982
82/83 03/01/1983
83/84 06/01/1984
85/86 22/02/1986
87/88 15/01/1988
88/89 27/12/1988
89/90 24/12/1989
90/91 03/12/1990
92/93 13/01/1993
93/94 25/02/1994
94/95 13/12/1994
95/95 14/12/1995
96/97 01/02/1997
98/99 29/01/1999
99/00 30/12/1999
03/04 14/03/2004
04/05 14/12/2004
06/07 30/11/2006
07/08 31/12/2007
08/09 30/12/2008
09/10 06/01/2010
10/11 21/01/2011
11/12 22/11/2011
Una prima considerazione che sicuramente emerge è la facilità e la costanza di realizzazione di questo fenomeno nel corso degli anni, solamente in 8 stagioni su 34 non si è verificato.
Individuati gli anni da analizzare proseguiamo nel ricercare un metodo numerico, che vada al di là della semplice osservazione di grafici, per verificare se la troposfera ha risentito del processo stratosferico. Andiamo quindi a prendere le velocità zonali in medio-alta stratosfera (10 hPa), le stesse in bassa stratosfera (150 hPa) e l’indice AO che viene misurato al livello del suolo, riportando di questi 3 parametri la media dei 30 giorni successivi al giorno di superamento della soglia e per le velocità zonali, tra parentesi, la media 78/16 del periodo:
Anno U10 U150 AO
78/79 36,53(34) 12,37(13,5) -2,019
79/80 47,72(28) 11,69(13) -2,344
80/81 57,31(39) 18,09(14,5) -0,052
81/82 10,08(6) 13,83(10,5) 0,724
82/83 47,70(34) 19,75(13,5) 1,112
83/84 53,41(34) 17,31(14) 0,531
85/86 20,72(17) 15,08(12) 0,553
87/88 53,38(28) 12,51(13) -0,276
88/89 62,89(38) 22,69(14) 2,719
89/90 48,86(38) 17,27(14) 1,101
90/91 42,62(37) 19,32(14,5) 1,204
92/93 47,09(28) 21,52(13) 2,290
93/94 28,25(17) 17,34(11,5) 1,155
94/95 46,55(39) 17,31(14,5) 0,390
95/96 46,59(39) 13,68(14,5) -2,037
96/97 49,34(24) 18,84(12) 1,915
98/99 29,66(26) 14,16(12) 0,269
99/00 52,60(38) 18,14(13,5) 1,039
03/04 24,41(6) 10,98(11) -0,099
04/05 48,58(39) 20,06(14,5) 2,299
06/07 40,79(37) 16,14(14,5) 2,063
07/08 42,07(37) 16,16(13,5) 0,679
08/09 40,42(37) 14,33(13,5) 0,740
09/10 18,31(34) 7,68(13,5) -2,089
10/11 41,61(27) 15,78(12,5) 0,801
11/12 43,73(36) 18,60(14) 2,101
Si nota come a fronte di velocità zonali a 10 hPa oltre la media del periodo in tutti gli anni (a parte l’estremo 09/10), quelle a quote più basse siano soggette a variazioni maggiori rispetto alla norma. Per ovviare, quindi, alla necessità di descrivere numericamente il grado di condizionamento (c) possiamo operare una semplice somma che abbia come addendi la differenza tra valore assoluto e media di velocità zonali a 150 hPa e il valore dell’Artic Oscillation:
c=ΔU150+AO
Anno c
78/79 -3,149
79/80 -3,654
80/81 3,538
81/82 4,054
82/83 7,362
83/84 3,841
85/86 3,633
87/88 -0,766
88/89 11,409
89/90 4,371
90/91 6,024
92/93 10,81
93/94 6,995
94/95 3,200
95/96 -2,857
96/97 8,755
98/99 2,429
99/00 5,679
03/04 -0,119
04/05 7,859
06/07 3,703
07/08 3,339
08/09 1,570
09/10 -7,909
10/11 4,081
11/12 6,701
Con una semplice operazione aritmetica possiamo verificare efficacemente quanto la troposfera è influenzata dalle vicende stratosferiche in questione, più il valore della tabella in alto è elevato più è incidente il condizionamento, viceversa più il valore è negativo più il disaccoppiamento tropo-strato è forte. I valori positivi spaziano tra gli 11,409 dell’88/89 e l’1,570 del 08/09, evidenziando quindi vari gradi di influenza mentre i valori negativi sono solamente 6 (dal -0,119 del 03/04 al -7,909 del 09/10). Palese quindi l’elevata probabilità di coupling tra i 2 livelli atmosferici di seguito ad un superamento della soglia a fronte di una certa rarità del fenomeno contrario.
Fase 2: verificare il differente comportamento della troposfera nei casi di c>0 e c<0
Applicata la formula per dare valenza numerica oggettiva a processi che analizzati graficamente avrebbero potuto cadere nella soggettività, andiamo ad analizzare il secondo punto, il comportamento della troposfera in entrambi i casi in oggetto e più nello specifico dell’indice AO, partendo da 10 giorni prima del superamento della soglia fino a 50 giorni dopo esso.


Esplicative e chiarissime le differenze negli effetti troposferici delle due situazioni opposte di c (positica e negativa). Nel primo caso abbiamo un’Artic Oscillation neutra nei giorni precedenti al superamento della soglia con rapido incremento a seguito di esso, tendenziale calo verso valori nuovamente neutri dopo il quarantesimo giorno, il che coinciderebbe con i precedenti studi che individuano in un periodo medio di 45-60 giorni il condizionamento troposferico a seguito di NAM>1,5; il secondo grafico mostra un indice AO ben negativo per tutto il periodo analizzato con tendenza alla neutralità verso il cinquantesimo giorno.
Per evidenziare le differenti modalità di reazione della troposfera nelle varie fasi di attività del Vortice Polare Stratosferico, dividiamo i dati in 3 periodi temporali: il primo in cui il VPS è in fase di sviluppo, il secondo dove abbiamo un VPS alla massima intensità ed infine il terzo in cui il VPS è in fase calante.



Vediamo tre differenti comportamenti dell’indice troposferico, i valori più alti li troviamo nel primo caso con valori in aumento già nei giorni precedenti al giorno 0, uniti però ad una breve fase neutra a metà del periodo di condizionamento, nel secondo caso abbiamo valori decisamente più stabili anche nei giorni antecedenti con modesto calo solo tra trentacinquesimo e quarantacinquesimo giorno, infine abbiamo il caso numero 3 che mostra un leggero lag nella trasmissione delle anomalie dalla stratosfera alla troposfera e una durata minore del condizionamento che porta a valori di AO negativi alla fine del periodo in analisi.
Fase 3: possibilità di prevedere in anticipo i casi di c<0
Analizzati i comportamenti dello strato di atmosfera a noi più prossimo proseguiamo con la ricerca di una causa scatenante che differenzia i casi di c>0 da quelli <0. Appurato che la stragrande maggioranza di eventi ricade nel primo caso, vanno analizzate le motivazioni che portano saltuariamente a differenti conseguenze partendo da uno stesso punto (NAM>1,5). Studiando uno ad uno gli indici teleconnettivi (ciclici, atmosferici, oceanici, solari, ecc.) non emerge nessuna connessione capace di portare ad una conclusione plausibile che potrebbe condurre ad una previsione di un caso rispetto all’altro, il che farebbe pensare a fattori di variabilità interna ed intrinseca al sistema e quindi impossibile da prevedere. L’unico fattore saliente è che dei 3 esempi con superamento soglia avvenuto successivamente ad un riscaldamento stratosferico di tipo major (87/88 – 98/99 – 03/04), 2 di questi hanno avuto c<0 e uno c=2,429, valore tra i più bassi di quelli positivi, il che potrebbe far intuire che una sorta di imprinting venga dato ad inizio stagione con annate più incini a situazioni di turbolenza atmosferica che poi sfocia nel disaccoppiamento tropo-strato. Andando ad analizzare più nel dettaglio, emergono configurazioni nette e contrapposte nei periodi che anticipano stagioni con condizionamento rispetto a stagioni con decoupling. Nelle figure sotto, che mostrano le anomalie gpt a 30 hPa, possiamo vedere rispettivamente i mesi di novembre che anticipano stagioni con c>5, 0<c<5 e c<0




Evidenti le differenze, nelle prime due immagini abbiamo anomalie negative ai poli e positive tra i 2 tropici (con particolare riferimento per la prima), sintomo di una B&D Circulation debole mentre le anomalie sono praticamente opposte nell’ultima immagine, quella che mostra gli anni in cui il condizionamento troposferico non è avvenuto, in cui la BDC risulta decisamente più intensa.
Fase 4: individuare possibili conseguenze comuni in casi di c<0
Veniamo al punto finale di questo studio, la ricerca di possibili conseguenze prevedibili a seguito di un disaccoppiamento post superamento soglia NAM. Ovviamente, data l’elevata cadenza e quindi le più disparate conseguenze, non è possibile effettuare lo stesso lavoro per i casi opposti. Da un’attenta analisi delle anomalie sulla colonna atmosferica, si nota che il periodo di decoupling in 5 casi su 6 è sfociato in un T-S-T event con innesco proprio dai disturbi troposferici dovuti al disaccoppiamento.




Conclusioni
Siamo riusciti, in questo lavoro, a descrivere numericamente il grado di condizionamento della troposfera a seguito di un superamento della soglia critica NAM di 1,5. Successivamente abbiamo mostrato graficamente il comportamento dell’AO in caso di decoupling e di coupling nei vari periodi stagionali ma i punti cruciali erano sicuramente gli ultimi 2 e cioè la possibilità di prevedere un evento di decoupling e conoscere in anteprima le conseguenze di questo evento raro. Ribadiamo le incertezze di questo studio che arrivano innanzitutto da una campionatura scarna per gli esempi più rilevanti e cioè quelli con c<0 e di conseguenza da possibili errori che potranno emergere solo nel corso dei prossimi anni. Un altro elemento di incertezza è la scarsa valenza statistica teleconnettiva del periodo che stiamo vivendo, abbiamo sotto gli occhi ogni anno ultimamente le difficoltà predittive derivanti da indici o da particolari pattern inevitabilmente mutati con il profondo cambiamento in atto (riscaldamento globale, maggior vapore acqueo in atmosfera, scioglimento dei ghiacci artici, ecc.). Tenendo ben presenti questi limiti credo che questa ricerca andrà comunque verificata e migliorata nei prossimi anni, con la speranza e non l’arroganza di poter comprendere maggiormente alcuni movimenti ancora parzialmente incompresi.
Autori Daniele Cavezzoni

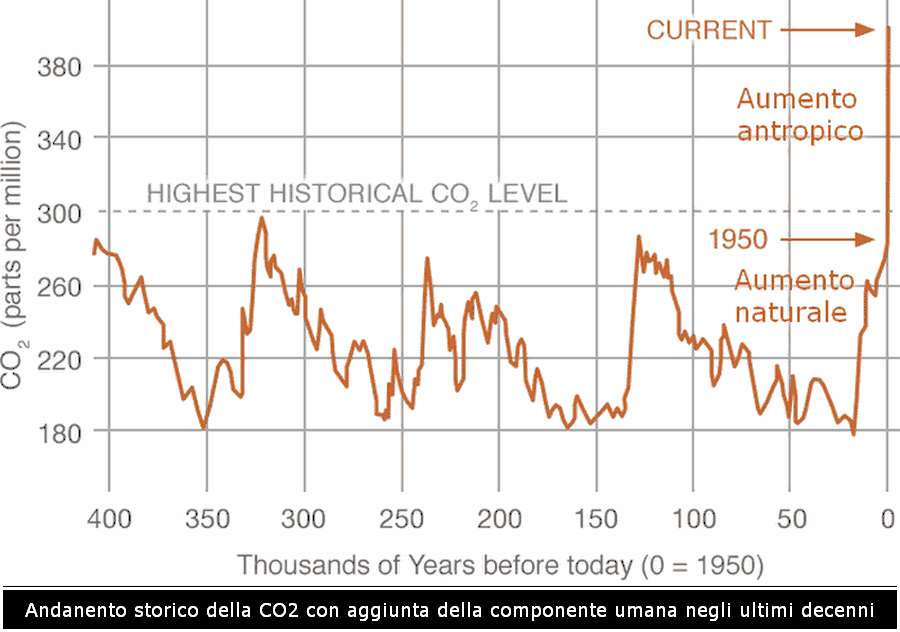 “I guai uno non se li va a cercare…!” Esclamava il buon Don Abbondio ne “I Promessi Sposi”, quando gli fu proposto di sposare Renzo e Lucia contro il parere del signorotto Don Rodrigo. Eppure c’è qualcuno che, al giorno d’oggi, i guai non solo se li va a cercare ma se li cagiona da sè. Questo “genio” è l’uomo che, pur conoscendo il prezzo cui sta andando incontro per sostenere un progresso insostenibile, rischia di mandare all’aria il mondo dei propri figli e dei propri nipoti, spingendolo verso orizzonti climatici e meteorologici praticamente inesplorati.
“I guai uno non se li va a cercare…!” Esclamava il buon Don Abbondio ne “I Promessi Sposi”, quando gli fu proposto di sposare Renzo e Lucia contro il parere del signorotto Don Rodrigo. Eppure c’è qualcuno che, al giorno d’oggi, i guai non solo se li va a cercare ma se li cagiona da sè. Questo “genio” è l’uomo che, pur conoscendo il prezzo cui sta andando incontro per sostenere un progresso insostenibile, rischia di mandare all’aria il mondo dei propri figli e dei propri nipoti, spingendolo verso orizzonti climatici e meteorologici praticamente inesplorati.













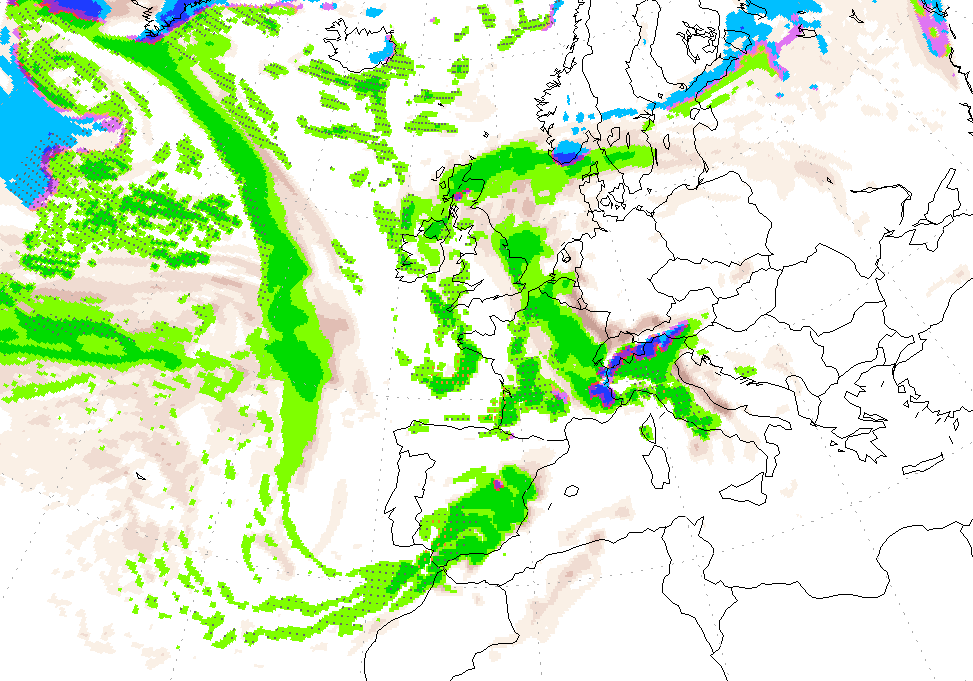 Il primo fine settimana della primavera meteorologica parte con la pioggia e il maltempo. Nulla di strano, visto e considerato che la primavera non è stagione dalla quale ci si possa aspettare la stabilità atmosferica, nè una particolare affidabilità climatica, bensì quella classica dinamicità che porta ad alternarsi a ritmi di samba il sole e la pioggia, il vento e le nuvole. E le nuvole, insieme alla pioggia, al vento e alle nevicate in montagna, si faranno notare a partire dal fine settimana tra il 4 e il 5 marzo.
Il primo fine settimana della primavera meteorologica parte con la pioggia e il maltempo. Nulla di strano, visto e considerato che la primavera non è stagione dalla quale ci si possa aspettare la stabilità atmosferica, nè una particolare affidabilità climatica, bensì quella classica dinamicità che porta ad alternarsi a ritmi di samba il sole e la pioggia, il vento e le nuvole. E le nuvole, insieme alla pioggia, al vento e alle nevicate in montagna, si faranno notare a partire dal fine settimana tra il 4 e il 5 marzo.
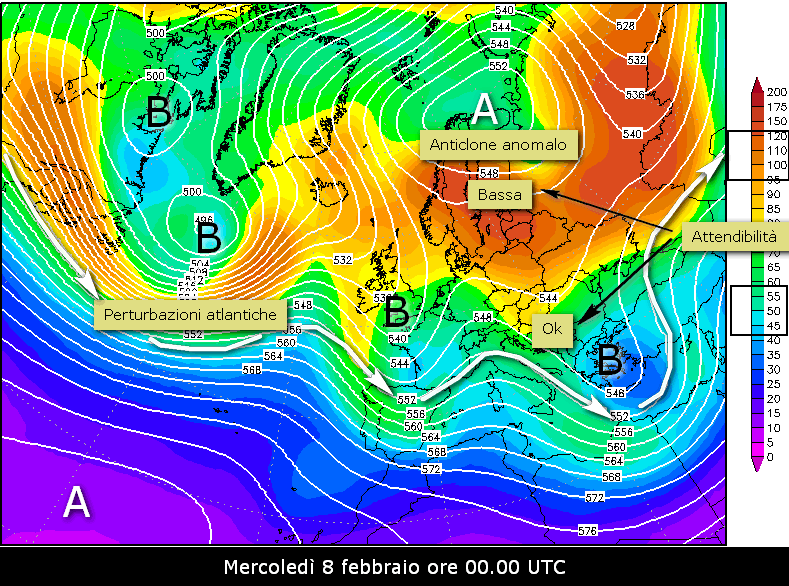 L’azione di erosione intrapresa dalle piovose correnti atlantiche sul blocco freddo che ancora resiste su gran parte dell’Europa centro-orientale, protetto da un campo di alta pressione riscontrabile a tutte le quote, sta per giungere a compimento. Con il passare dei giorni l’asse delle correnti sull’Italia porterà sempre più vistosamente dai quadranti meridionali, accompagnandosi al passaggio di diversi corpi nuvolosi.
L’azione di erosione intrapresa dalle piovose correnti atlantiche sul blocco freddo che ancora resiste su gran parte dell’Europa centro-orientale, protetto da un campo di alta pressione riscontrabile a tutte le quote, sta per giungere a compimento. Con il passare dei giorni l’asse delle correnti sull’Italia porterà sempre più vistosamente dai quadranti meridionali, accompagnandosi al passaggio di diversi corpi nuvolosi.
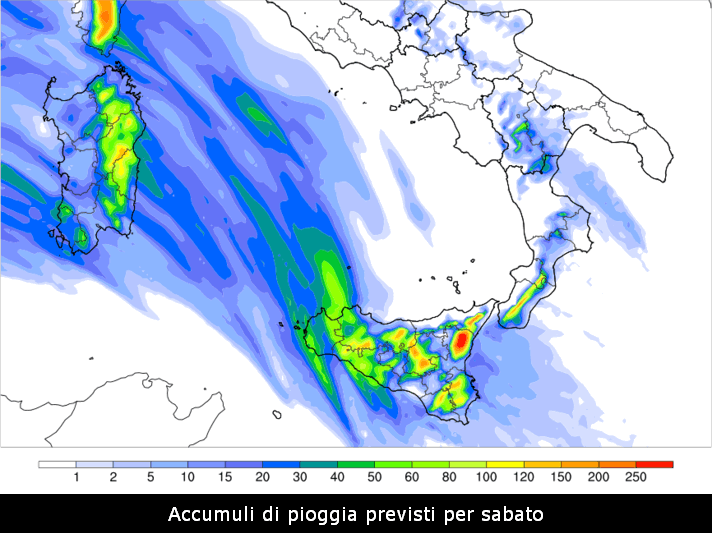 Cambio della guardia sul fronte del maltempo con l'attenzione che tra il 21 e il 23 gennaio passerò rapidamente dalle regioni appenniniche dell'Italia centrale alle isole Maggiori e poi all'estremo sud. Lungo la ferita ancora aperta dall'aria fredda che dai giorni dell'Epifania non ha ancora oggi esaurito le sue velleità di conquista sul Mediterraneo, si sta infatti approfondendo un nuovo vortice ciclonico in fase di risalita dal nord Africa e successivo approfondimento sui nostri mari di ponente. Il disegno generale alla scala sinottica ci mostra infatti il flusso di aria fredda legato al vortice ciclonico ancora presente sul Mediterraneo, spingere fin sul nord Africa e da qui andare in conflitto con il nastro più mite e umido che si troverà a scorrergli sotto puntando l’Italia sotto forma di Scirocco.
Cambio della guardia sul fronte del maltempo con l'attenzione che tra il 21 e il 23 gennaio passerò rapidamente dalle regioni appenniniche dell'Italia centrale alle isole Maggiori e poi all'estremo sud. Lungo la ferita ancora aperta dall'aria fredda che dai giorni dell'Epifania non ha ancora oggi esaurito le sue velleità di conquista sul Mediterraneo, si sta infatti approfondendo un nuovo vortice ciclonico in fase di risalita dal nord Africa e successivo approfondimento sui nostri mari di ponente. Il disegno generale alla scala sinottica ci mostra infatti il flusso di aria fredda legato al vortice ciclonico ancora presente sul Mediterraneo, spingere fin sul nord Africa e da qui andare in conflitto con il nastro più mite e umido che si troverà a scorrergli sotto puntando l’Italia sotto forma di Scirocco. 